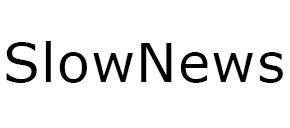La politica nella visione carismatica di Chiara Lubich’.
La tradizione delle definizioni relazionali
Quello descritto da Chiara è un umanesimo ricostruttivo dell’uomo e della città, che non si pone consapevolmente obiettivi politici, ma li realizza.
Quello di Chiara non è dunque un pensiero politico nel senso corrente;
si potrebbe definire invece come un pensiero carismatico sulla città, sulla polis; esso attinge ad un livello più profondo del comune pensiero politico, è un “vedere” e un pensare che mette in luce la radice relazionale alla quale diver-si pensieri politici possono ispirarsi.
Si tratta di un umanesimo completo, di cui la dimensione politica è soltanto un’espressione.
Del resto, nella distruzione della guerra, la polis non c’era, nel senso che era venuta degenerando la specifica dimensione della cittadinanza.
L’umanesimo innescato da Chiara la ricostruisce, è un insieme di pensiero e di azione costruttivi della città;
la relazione umana che viene ritessuta, che permette il ristabilirsi delle leggi e delle virtù civiche, è la sostanza stessa della cittadinanza, la condizione uni-taria di ogni successiva politica.
Questa sintetica descrizione che Chiara compie dell’azione delle prime focolarine nella città di Trento, viene pronunciata il 9 giugno nel 2000, in occasione del primo congresso del Movimento politico per l’unità.
Nello spiegare tale azione, Chiara mette insieme alcuni elementi fondamentali:
1) la libera decisione delle focolarine di amare;
2) privilegiando gli ultimi che venivano soccorsi con i beni dei più abbienti, cioè creando, tra i due gruppi, legami di fraternità;
3) ottenendo così una uguaglianza attraverso la frater-nità. Questi tre elementi insieme: libertà, uguaglianza, fraternità, creano le condizioni della vita politica.
In questo discorso fondativo, Chiara rilegge la storia del Movimento dei Focolari e delle sue relazioni con la politica, nell’ottica della fraternità, che viene proposta come lo specifico del nuovo Movimento politico.
Così ella si esprime:
Chiediamoci: qual è lo specifico del Movimento dell’unità?
Sappiamo che la redenzione attuata da Gesù sulla croce trasforma interiormente tutti i legami umani immettendovi l’amore divino e rendendoci così fratelli.
Ora questo ha un profondo significato per il nostro Movimento, se pensiamo che il grande progetto politico della modernità prevedeva, come sintetizza il motto della rivoluzione francese, “libertà, uguaglianza, fraternità”.
Ma se i primi due principi hanno conosciuto forme parziali di attuazione, la fraternità invece, a dispetto delle dichiarazioni formali, sul piano politico è stata “pressoché dimenticata.
Proprio questa invece può essere la caratteristica specifica del nostro Movimento: la fraternità; e per essa acquistano significati nuovi e potranno venire più pienamente raggiunte anche la libertà e l’uguaglianza.
Di fraternità, in effetti, nel mondo politico, sia a livello dell’azione, sia nell’ambito della riflessione accademica, in quel tempo non si poteva parlare senza essere fraintesi o derisi.
E questo era ed è un segno della crisi profonda che la politica, teorica e pratica, sta attraversando, quando si riduce ad in-seguire le inclinazioni dell’elettorato piuttosto che proporre programmi seri e lungimiranti;
oppure quando trasforma i problemi politici in questioni di polizia e di ordine pubblico;
o quando preferisce affidarsi alle armi piuttosto che affrontare le cause vere dell’ingiustizia interna e internazionale;
o facendosi esecutrice passiva di interessi economici talmente grandi da sfuggire ad ogni controllo.
In ognuno di questi casi, la politica tradisce se stessa e si riduce a qualche cosa d’altro, perché non sa più che cosa essa è.
L’approccio chiariano alla politica si inserisce invece, dandole un contributo originale, nella grande tradizione delle definizioni relazionali della politica, basate, appunto, sull’interpretazione della natura del legame di cittadinanza: parte, cioè, dalle fondamenta del discorso politico.
È Aristotele ad iniziare tale ricca e composita tradizione, definendo la relazione tra i cittadini come una relazione di amicizia basata sull’utile, quando l’utile è il bene di tutti’.
Nella nozione aristotelica di bene comune, esso non è costituito soltanto dalla disponibilità di beni materiali comuni, di infrastrutture, di istituzioni: esso è caratterizzato dalla comune volontà di costruire le condizioni della vita felice, che è tale perché razionale e buona (Aristotele, Etica nicomachea, IX, 6, 1167a, a cura di C. Mazzarelli, Rusconi, Milano 1996).
L’amicizia politica è dunque una relazione che richiede le virtù civili, la capacità da parte di ciascuno di posporre il proprio interesse privato, per conseguire un bene che solo insieme agli altri può essere raggiunto.
Egli fornisce anche altre definizioni di politica’, ma le definizioni di tipo relazionale, alle quali egli dà inizio, sono genetico-descrittive, mostrano cioè su quali basi antropologiche si formi la società politica.
Questa tradizione ha fornito strumenti interpretativi essenziali lungo la storia del pensiero politico.
La dimensione relazionale è determinante, ad esempio, nella filosofia politica di Agostino. Come è noto, egli descrive la vita di due città, caratterizzate dal fatto che la relazione tra i cittadini dell’una è molto differente dalla relazione tra i cittadini dell’altra.
Esistono cioè due forme di cittadinanza radicalmente diverse; la cittadinanza della città divina, dove i cittadini sono uniti dall’amore sociale e agapico, dalla volontà di bene gli uni per gli altri; e la cittadinanza della città terrena, caratterizzata dall’amor proprio e privato’.
Lungo la storia le due città sono mescolate fra loro ed è difficile distinguerle; nello stesso parlamento possiamo incontra-re entrambi i tipi di cittadini: quelli che hanno l’amore agapico-sociale e per questo costruiscono il bene comune, e quelli che hanno l’amor proprio, cioè privato, e, attraverso la politica, lavorano per se stessi’.
Ma solo l’amore sociale è in grado, secondo Agostino, di costituire la vera cittadinanza (cit. Sant’Agostino, La città di Dio, XIV, 7, 2; in La città di Dio, II (Libro XI-XVIII), Sant’Agostino, La Genesi alla lettera (De Genesi ad litteram).
La relazione basata sugli interessi privati non è politica; senza amore non c’è una vera città, non c’è polis, non c’è politica.
Passando all’età moderna, la società politica è costruita, secondo Thomas Hobbes, attraverso un contratto nel quale ciascun uomo rinuncia a tutti i propri diritti, per dare vita ad una istituzione politica in cui il potere è assoluto — il Leviatano — proprio per proteggere ciascuno dall’aggressività degli altri.
È l’aggressività di ciascuno nei confronti di tutti a caratterizzare, per Hobbes, l’essenziale relazionalità umana; che sia causata da brama di guadagno, dalla ricerca della sicurezza personale o da quella della gloria, l’esito è in ogni caso distruttivo e genera un’insicurezza e paura permanenti per la propria vita; l’istituzione che ne deriva ne è lo specchio: gli esseri umani vi sono sudditi, non cittadini'(T. Hobbes, Leviathan, I, XIII; ín Leviathan, with selected variants from the Latin edition).
Al contrario, John Locke assume a base del contratto che dà vita alla società politica una diversa visione antropologica. Certamente, in Locke vi sono anche altre motivazioni che richiedono di costituire una società politica, in particolare l’elemento della difesa della proprietà. Ma già prima di unirsi politicamente gli esseri umani sono legati in società e riconoscono un obbligo di amore reciproco’.
Locke coglie questa visione sociale della natura umana dalla Bibbia, della quale è lettore appassionato e, in particolare, dalla riflessione del grande teologo anglicano Richard Hooker, che considerava l’amore reciproco non solo come un comandamento evangelico, ma come un dovere che gli esseri umani comprendono sulla base dell’intelligenza naturale’.
Per questo, secondo Locke, gli esseri umani vivono già socialmente prima di stabilire il contratto politico. Il governo che scaturisce da tale impostazione antropologica dev’essere basato sulle leggi e sul consenso; è in effetti il progenitore del moderno Stato di diritto (J. Locke, The Second Treatise of Government, eit., p. 116).
Vediamo dunque che concentrarsi sulla dimensione antropologica e relazionale della cittadinanza, e fare ricorso anche al vocabolario della socialità e dell’amore, o ai loro contrari, non è affatto improprio, ma si inserisce in una tradizione rilevante nella storia del pensiero politico.
Perderla, rinunciando a questo tipo di linguaggio, significherebbe perdere contenuti essenziali della storia umana. Chiara, al contrario, la recupera, portando alla luce un percorso storico — lo “zoccolo”, com’ella lo chiamava — sul quale poggiare il proprio pensiero, reinterpretando la tradizione per continuare a costruire.
La relazione d’amore, i modi con í quali costruirla, le difficoltà che essa incontra, hanno dunque un grande rilievo nella riflessione di Chiara sulla politica. Ed è logico che ella cerchi di comunicare a coloro che si impegnano in politica la “risorsa” fondamentale per condurla, cioè la fonte dell’amore stesso.
Tale fonte, per Chiara, è Dio; ed è in Cristo che essa si manifesta pienamente agli uomini. «Gesù — spiega Chiara — è l’Uomo, l’uomo perfetto, che riassume in sé tutti gli uomini ed ogni verità e spinta che essi possono sentire per elevarsi al proprio posto»”.
Ma non è il Gesù onnipotente dei miracoli, o quello che trascina e sfama le folle, il Gesù che ella avverte come più vicino ai compiti del politico. Per Chiara l’amore più grande si manifesta, in Gesù, nel suo abbandono: è dunque Gesù Abbandonato che ella propone come modello del politico nel suo intervento al primo Congresso del Movimento politico per l’unità”, proprio perché Egli è Colui che abbraccia tutte le divisioni, le sconfitte, le lontananze presenti nell’umanità e le riconduce all’unità con Dio.
Il grido di Gesù Abbandonato, spiega Chiara, «è il più bel Canto, ché l’Amore che Egli ci dona è Dio: è divino il suo dolore e quindi Dio il suo Amore»” .
Anche la politica è dolore che diviene amore, è scelta di dedicarsi alla soddisfazione dei bisogni, alla realizzazione dei diritti degli esseri umani.
Se rimanesse solo dolore, si volterebbe in rassegnazione o in odio, che sono due forme di guerra: contro se stessi o contro gli altri.
Se invece il dolore diventa amore, la politica prende il posto della guerra, e sorge la città unita: «Gesù Abbandonato è il più grande Amore, l’Amore degli Amori, […] perché è Unità»”.
Proprio parlando ad alcune centinaia di sindaci e amministratori di città europee, convenuti ad Innsbruck nel 2000, ella approfondisce questo suo centrale messaggio.
Chiara infatti vede con realismo le difficoltà, i conflitti, le tragedie che la politica deve affrontare e superare. E dunque da una parte propone, con Gesù Abbandonato, un modello che seppe attraversare fino in fondo il conflitto, rimanendo fedele al suo compito fino al sacrificio estremo e fino al suo riabbandonarsi, con fiducia, nel Padre.
Dall’altra, e proprio per questo, vede nell’amore politico non un sentimento, non un generico volersi bene che distolga gli occhi dal crudo dell’esistenza e neppure un richiamo etico che giudichi del bene e del male senza prendere parte con efficacia all’azione, ma il modo specifico con il quale la politica affronta e risolve i problemi della società. Lo possiamo comprendere meglio seguendo Chiara in due percorsi im-portanti.
Il primo riguarda il ruolo di Maria; se Gesù è il modello del politico, Maria, per Chiara, è colei che deve condurre il Movimento politico; scrive infatti: Maria è colei che canta: «Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente» (Le 1, 49).
In lei Dio deposita il suo disegno per l’umanità: in lei rivela la sua misericordia per gli uomini, distrugge i falsi progetti dei superbi, abbatte i potenti dai troni e innalza gli umili, ristabilisce la giustizia, distribuisce le ricchezze. Chi, dunque, più politico di Maria?
Compito del Movimento dell’unità è contribuire a realizzare nella storia ciò che Maria annuncia come già compiuto in sé’.
Il “Magnificat” di Maria è per Chiara la sintesi del programma del Movimento; ad ogni enunciazione di Maria corrisponde un diritto violato e una concreta azione politica da intraprendere.
Ma Chiara, sottolineando il “già compiuto” in Maria, indica una metodologia precisa al Movimento: bisogna, prima di agire fuori, avere già realizzato fra noi quello che si vuole costruire per tutti.
Maria è l’antidoto ad ogni ideologia. Il secondo modo per comprendere la specificità dell’azione politica proposta da Chiara, è quello di scavare dentro le parole: “Amore degli Amori”, tante volte ripetute, ma forse non sempre comprese nella loro portata.
È l’espressione che la tradizione attribuisce a Bernardo di Chiaravalle, per designare l’Eucaristia”, intesa come il sacramento che esprime il sacrificio di Cristo e dunque il vertice del suo amore. La incontriamo poi con continuità nel pensiero e nella sensibilità ecclesiali successivi, fino ad oggigiorno.
In Chiara l’Amore degli amori diviene l’Amore che abbraccia il dolore e la disunità e li riconcilia; mantiene dunque il suo significato e la sua effica-cia eucaristici ma, in quanto amore politico, penetra attivamente nella storia attuandovi laicamente ciò che è tipico dell’amore eucaristico;
Chiara spiega: Il compito dell’amore politico, infatti, è quello di creare e custodire le condizioni che permettono a tutti gli altri amori di fiorire:
l’amore dei giovani che vogliono sposarsi e hanno bisogno di una casa e di un lavoro,
l’amore di chi vuole studiare e ha bisogno di scuole e di libri,
l’amore di chi si dedica alla propria azienda e ha bisogno di strade e ferrovie, di regole certe…
La politica è perciò l’amore degli amori, che raccoglie nell’unità di un disegno comune la ricchezza delle persone e dei gruppi, consentendo a ciascuno di realizzare liberamente la propria vocazione.
Ma fa pure in modo che collaborino tra loro, facendo incontrare i bisogni con le risorse, le domande con le risposte, infondendo in tutti la fiducia gli uni negli altri.
(L’espressione “amore degli amori” in riferimento all’Eucaristia viene attribuita a Bernardo da numerosi e prestigiosi autori, quali Francesco di Sales (cf. la lettera alla Chantal citata da P.G. Galizia, La vita di S. Francesco de Sales, vescovo e principe di Geneva, fondatore dell’ordine della Visitazione, Venezia 1762, p. 367) e Alfonso Maria de’ Liguori (La vera Sposa di Gesù Cristo [1760-61], XVIII, 235, in Opere ascetiche, voli. XIV-XV, CSSR, Roma 1935, disponibile in I Edizione IntraText CT, Copyright Èulogos 2007, wv,v. intratext.com; Pratica di amar Gesù Cristo [1768], in Opere ascetiche, Vol. I, pp. 1-243, CSSR, Roma 1933, disponibile in I Edizione IntraText CT, Copyright Èulogos 2007, wwwintratext. com), fino al più vicino a noi Annibale Maria di Francia (A Gesù diletto deì cuori, Luglio 1899; in Dattiloscritti, voi 54, p. 27; nel sito ufficiale difrancia.net).
Tali autorevoli precedenti hanno fatto scuola e in molte omelie, soprattutto in occasione del Giovedì Santo, il riferimento a Bernardo è abituale.
Basti citare l’Esortazione apostolica postsinodale Sacramentum caritatis del Santo Padre Benedetto XVI all’episcopato, al clero alle persone consacrate e ai fedeli laici sull’eucaristia fonte e culmine della vita e della missione della Chiesa, Roma, 22 febbraio 2007, dove l’Eucaristia è definita appunto “sacramento della carità”.