[pag. 932] Questa annotazione, iniziata dodici anni fa, in assenza di precedenti lavori consimili, ha goduto per il presente volume del conforto della pubblicazione, nel frattempo intervenuta, di alcune edizioni annotate, in particolare di quelle di Bernard Brun (Flammarion, 1986) e di Jacques Robichez e Brian Rogers nella nuova «Pléiade» del 1989. Naturalmente — secondo l’uso di questa edizione, che, a costo di appesantire le note con continui rimandi, rinvia sempre alle sue fonti — i curatori sono citati ogni volta che il loro commento è stato utilizzato, e qui li ringraziamo. La mia gratitudine va pure all’indimenticabile direttore di questa edizione, Luciano De Maria, a Giovanni Macchia, che ha promosso e seguito il lavoro con la sua insuperata competenza proustiana, a Giorgio Agamben, Aurelio Andreoli, Mara Fazio, Mario Molinari, Michele Surdi e Niccolò Zapponi che mi hanno soccorso su alcuni problemi esegetici; e a Marco Beck e Gabriella Mezzanotte per lo vigile opera redazionale.
D.G.
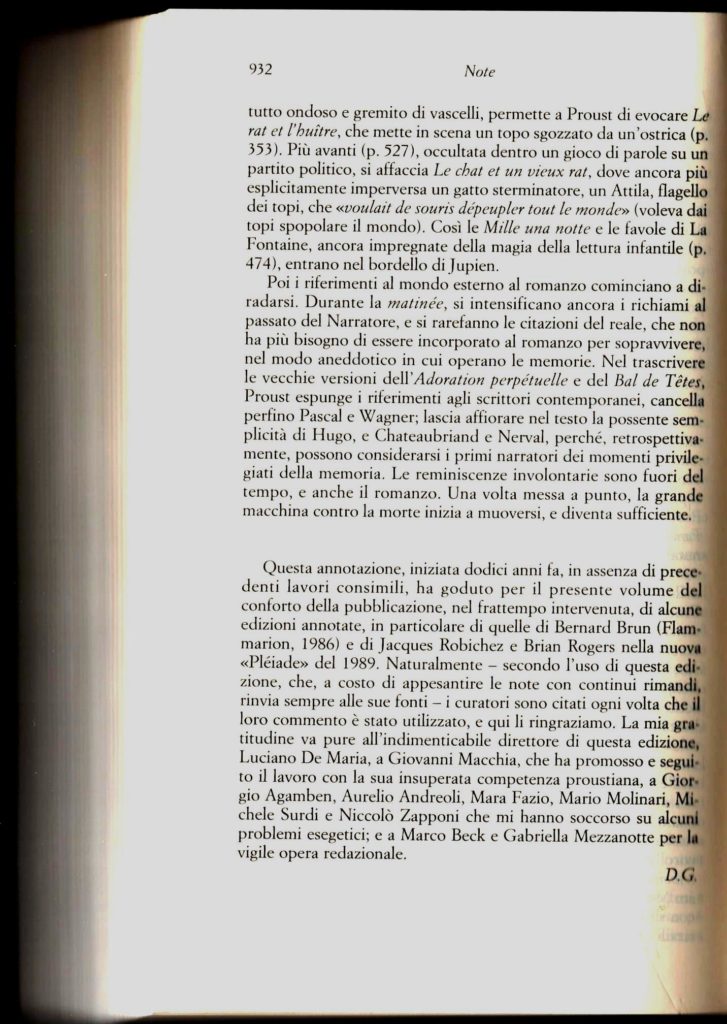
Il Tempo ritrovato
[…] Et bien loin de me croire malheureux de cette vie sans amis, sans causerie, comme il est arrivé aux plus grands de le croire, je me rendais compte que les forces d’exaltation qui se dépensent dans l’amitié sont une sorte de porte-à-faux visant une amitié particulière qui ne mène à rien et se détournant d’une vérité vers laquelle elles étaient capables de nous conduire. Mais enfin, quand des intervalles de repos et de société me seraient nécessaires, je sentais que bien plutôt que les conversations intellectuelles que les gens du monde croient utiles aux écrivains, de légères amours avec des jeunes filles en fleurs seraient un aliment choisi que je pourrais à la rigueur permettre à mon imagination semblable au cheval fameux qu’on ne nourrissait que de roses. […]
[…] Ebbene, lungi dal credermi infelice di questa vita senza amici, senza conversazione, come ai più grandi è capitato di credersi, mi rendevo conto che le forze d’esaltazione che si spendono nell’amicizia sono una sorta di sporgenza verso un’amicizia particolare che non porta a nulla e allontana da una verità cui esse sarebbero capaci di condurci. Ma, insomma, quando mi fosse stata necessaria qualche pausa di riposo e di compagnia, sentivo che assai più delle conversazioni intellettuali che la gente di mondo ritiene utili agli scrittori, leggeri amori con fanciulle in fiore sarebbero stati, a rigore, un alimento scelto da consentire alla mia immaginazione, simile al cavallo famoso che veniva nutrito solo di rose. […]
Il giovane Lucio, ospite del ricco Milone e di sua moglie Pànfile, esperta di magia, riesce a conquistarsi i favori della servetta Fòtide e la convince a farlo assistere di nascosto a una delle trasformazioni cui si sottopone la padrona. Alla vista di Pànfile che, grazie a un unguento, si muta in gufo, Lucio prega Fotide che lo aiuti a sperimentare su di sé tale metamorfosi. Fotide accetta, ma sbaglia unguento, e Lucio diventa asino, pur mantenendo facoltà raziocinanti umane.
Lucio apprende da Fotide che, per riacquistare sembianze umane, dovrà cibarsi di rose: via di scampo che, subito cercata, è rimandata sino alla fine del romanzo da una lunga serie di peripezie che l’asino incontra. Infine, giunto a Corinto Lucio apprende in sogno che l’indomani ci sarà una solenne festa in onore di Iside; nel corso della cerimonia mangia le rose che adornano il sistro di un sacerdote, riprendendo così forma umana. In segno di riconoscenza si consacra devotamente alla dea, entrando nel ristretto numero di adepti al culto dei misteri isiaci.
L’asino d’oro (Asinus aureus), è un’opera scritta da Lucio Apuleio nel II secolo d.C. Il secondo titolo è citato da sant’Agostino nel De civitate Dei (XVlll, 18). È l’unico romanzo della letteratura latina pervenuto interamente fino ad oggi e insieme al Satyricon di Petronio, pervenutoci solo parzialmente, costituisce l’unica testimonianza del romanzo antico in lingua latina.
Degli undici libri, i primi tre sono occupati dalle avventure del protagonista, il giovane Lucio (omonimo dell’autore, a cui forse proprio dal protagonista venne attribuito tale nome) prima e dopo il suo arrivo a Hypata in Tessaglia (tradizionalmente terra di maghi). Coinvolto già durante il viaggio nell’atmosfera carica di mistero che circonda il luogo, il giovane manifesta subito il tratto distintivo fondamentale del suo carattere, la curiosità, che lo conduce ad incappare nelle trame sempre più fitte di sortilegi che animano la vita della città.
Il Tempo ritrovato
[pag. 686] Nemmeno a casa mia avrei lasciato che si venisse a trovarmi nei miei momenti di lavoro, perché il dovere di realizzare la mia opera prevaleva su quello della cortesia o anche della bontà. Sicuramente avrebbero insistito, loro che non mi vedevano da tanto tempo, ora che mi avevano ritrovato e mi credevano guarito, venendo quando le fatiche della loro giornata o della loro vita fossero finite o interrotte, e allora con lo stesso bisogno di me che avevo avuto io un tempo di Saint-Loup; e perché — me n’ero già accorto a Combray quando i miei genitori mi rimproveravano proprio nel momento in cui avevo fatto, a loro insaputa, i più lodevoli proponimenti — gli orologi interiori assegnati agli uomini non sono tutti regolati sulla stessa ora.
Uno suona l’ora del riposo mentre l’altro suona quella del lavoro, uno quella del castigo che il giudice deve infliggere quando nel colpevole è già suonata da tempo quella del pentimento e del perfezionamento interiore. Ma a chi fosse venuto a trovarmi o m’avesse fatto cercare io avrei avuto il coraggio di rispondere che avevo, per cose essenziali di cui era necessario che venissi messo al corrente senza indugio, un urgente, capitale appuntamento con me stesso.
E tuttavia, sebbene vi sia uno scarso rapporto fra il nostro io vero e l’altro, a causa dell’omonimia, e del corpo in comune fra i due, l’abnegazione che ci fa sacrificare i doveri più facili sembra agli altri egoismo. D’altronde, non sarebbe forse stato per occuparmi di loro che sarei vissuto lontano da quanti si sarebbero lamentati di non vedermi, per occuparmi di loro più a fondo di quanto mai avrei potuto fare assieme a loro, per cercare di rivelarli a loro stessi, di realizzarli?
A che cosa sarebbe servito se, ancora per anni, avessi perso delle serate a far scivolare sull’eco appena svanita delle loro parole il suono altrettanto vano delle mie, per lo sterile piacere di un contatto mondano che esclude ogni [pag. 687] penetrazione? Non sarebbe stato meglio se i gesti che facevano, le parole che dicevano, la loro vita, la loro natura, io avessi cercato di descriverne la curva, di estrarne la legge?
Purtroppo avrei dovuto lottare contro l’abitudine di mettersi al posto degli altri, che favorisce, è vero, la concezione di un’opera, ma ne ritarda l’esecuzione. Infatti essa induce a sacrificare agli altri, per una superiore cortesia, non solo il proprio piacere, ma anche il proprio dovere, quando, mettendosi al posto degli altri, tale dovere — qualunque esso sia, foss’anche, per chi non può prestare alcun servizio al fronte, di rimanere nelle retrovie dove è utile — appare, cosa che in realtà non è, come il nostro piacere.
Ebbene, lungi dal credermi infelice di questa vita senza amici, senza conversazione, come ai più grandi è capitato di credersi, mi rendevo conto che le forze d’esaltazione che si spendono nell’amicizia sono una sorta di sporgenza verso un’amicizia particolare che non porta a nulla e allontana da una verità cui esse sarebbero capaci di condurci. Ma, insomma, quando mi fosse stata necessaria qualche pausa di riposo e di compagnia, sentivo che assai più delle conversazioni intellettuali che la gente di mondo ritiene utili agli scrittori, leggeri amori con fanciulle in fiore sarebbero stati, a rigore, un alimento scelto da consentire alla mia immaginazione, simile al cavallo famoso che veniva nutrito solo di rose. [1]
Di colpo tornavo a desiderare ciò che avevo sognato a Balbec, quando, senza conoscerle ancora, avevo visto passare sullo sfondo del mare Albertine, Andrée e le loro amiche. Ma, ahimè!, quelle di cui provavo, proprio in quel momento, un desiderio così forte, non potevo più sperare di trovarle. L’azione degli anni, che aveva trasformato ogni essere da me incontrato oggi, compresa la stessa Gilberte, aveva fatto sicuramente di tutte quelle che sopravvivevano, come avrebbe fatto di Albertine se non fosse morta, delle donne troppo diverse dal mio ricordo.
[pag. 688] Soffrivo d’essere intimamente costretto a raggiungerle, giacché il tempo che muta gli esseri non modifica l’immagine che di loro abbiamo serbata. Niente è più doloroso di questo contrasto fra l’alterazione degli esseri e la fissità del ricordo, quando ci rendiamo conto che ciò che ha conservato tanta freschezza nella nostra memoria non può più averne alcuna nella vita, che non possiamo, all’esterno, avvicinarci a ciò che ci sembra così bello dentro di noi, a ciò che suscita in noi il desiderio, per altro così individuale, di rivederlo, se non cercandolo in un essere della stessa età, vale a dire in un altro essere. Il fatto è che quanto sembra unico in una persona desiderata non appartiene ad essa.
Spesso ne avevo avuto il sospetto; ma il tempo trascorso me ne dava una prova più completa, giacché dopo vent’anni io volevo spontaneamente cercare, al posto delle fanciulle conosciute un tempo, quelle che possedevano ora la giovinezza che esse avevano allora. (D’altronde non è solo il risveglio dei nostri desideri carnali a non corrispondere ad alcuna realtà in quanto non tiene conto del tempo perduto. A volte mi succedeva di desiderare che, grazie a un miracolo, mi comparissero accanto, rimaste vive contrariamente a quanto avevo creduto, la nonna, Albertine. Mi sembrava di vederle, il mio cuore si slanciava verso di loro. Dimenticavo solo una cosa: che, se fossero state vive, Albertine avrebbe avuto all’incirca l’aspetto offertomi da Madame Cottard a Balbec, e la nonna, a più di novantacinque anni, non mi avrebbe mostrato nulla del bel viso calmo e sorridente con cui ancora adesso la immaginavo, non meno arbitrariamente di come si attribuisce una barba al Padreterno o nel XVII secolo si raffiguravano gli eroi di Omero ridicolmente abbigliati da gentiluomini e senza tener conto della loro antichità.)
Guardavo Gilberte e non pensai: «Vorrei rivederla», ma le dissi che mi avrebbe sempre fatto piacere essere invitato a casa sua assieme a delle ragazze molto giovani,[pag. 689] possibilmente povere, in modo da poterle fare contente qualche piccolo regalo, senza chiedere loro, d’altronde, più che di far rinascere in me le fantasticherie, le tristezze d’un tempo, e forse, un giorno improbabile, un casto bacio. Gilberte sorrise, e parve poi riflettere seriamente fra sé.[1]
Come Elstir voleva vedere incarnata davanti ai propri occhi, in sua moglie, la bellezza veneziana tante volte dipinta nei suoi quadri, io davo a me stesso la scusa d’essere attratto da un certo egoismo estetico verso le belle donne che potevano farmi soffrire, e avevo un certo sentimento di idolatria per le future Gilberte, le future duchesse di Guermantes, le future Albertine che avrei potuto incontrare e che, mi sembrava, avrebbero potuto ispirarmi, come uno scultore che s’aggira fra bei marmi antichi.
Avrei dovuto pensare, tuttavia, che anteriore a ciascuna era il mio sentimento del mistero in cui esse erano immerse, e che dunque, più che chiedere a Gilberte di farmi conoscere delle fanciulle, avrei fatto meglio ad andare là dove niente ci avvicina a loro, dove fra loro e noi sentiamo qualcosa di invalicabile, dove a pochi passi di distanza, sulla spiaggia, ai bagni, si sente che l’impossibile ci separa da loro.
E così che il mio sentimento del mistero aveva potuto applicarsi via via a Gilberte, alla duchessa di Guermantes, ad Albertine, a tante altre. Certamente l’ignoto, e quasi l’inconoscibile, era diventato il noto, il familiare, indifferente o doloroso, ma aveva conservato qualcosa di ciò che era stato il suo fascino. […]
Il Tempo ritrovato note [pag. 1035]
p 687 [1] Forse una reminiscenza di Svetonio, De vita XII Caesarum, Caligola LV: «Per quanto concerne il suo cavallo Incitatus… oltre a una scuderia di marmo e una mangiatoia d’avorio, oltre a gualdrappe di porpora e briglie tempestate di pietre preziose, arrivò a fargli co-struire un palazzo, attribuirgli schiavi e mobili, per ricevere magni-i icamente le persone invitate in suo nome; progettò perfino, dicono, di farlo console».
p. 689 [1] Qui il modello di Gilberte è Jeanne Pouquet, un amore giovanile di Proust. Jeanne aveva sposato Gaston de Caillavet; una sera del 1912, alle undici e mezza, Proust si presentò da loro, a chiedere di vedere la figlia, Simone: «Non la vedo da tanto tempo, forse non la vedrò più, e quando lei avrà l’età del primo ballo io sarò troppo vecchio per uscire». Simone fu mandata a chiamare; aveva sedici anni: Proust scrisse alla madre una lettera che cominciava così: «Eccomi innamorato di vostra figlia» (Corr. XII, p. 136; e cfr. Painter, pp. 509-10 e 554).
Le Temps Retrouvé
[…] Même chez moi, je ne laisserais pas de gens venir me voir dans mes instants de travail, car le devoir de faire mon oeuvre primait celui d’être poli ou même bon. Ils insisteraient sans doute, eux qui ne m’avaient pas vu depuis si longtemps, venant de me retrouver et me jugeant guéri, venant quand le labeur de leur journée ou de leur vie était fini ou interrompu, et ayant alors ce même besoin de moi que j’avais eu autrefois de Saint-Loup ; et parce que, comme je m’en étais déjà aperçu à Combray quand mes parents me faisaient des reproches au moment où je venais de prendre à leur insu les plus louables résolutions, les cadrans intérieurs qui sont départis aux hommes ne sont pas tous réglés à la même heure. L’un sonne celle du repos en même temps que l’autre celle du travail, l’un celle du châtiment par le juge quand chez le coupable celle du repentir et du perfectionnement intérieur est sonnée depuis longtemps. Mais j’aurais le courage de répondre à ceux qui viendraient me voir ou me feraient chercher, que j’avais, pour des choses essentielles au courant desquelles il fallait que je fusse mis sans retard, un rendez-vous urgent, capital, avec moi-même. Et pourtant, bien qu’il y ait peu de rapport entre notre moi véritable et l’autre, à cause de l’homonymat et du corps commun aux deux, l’abnégation qui vous fait faire le sacrifice des devoirs plus faciles, même des plaisirs, paraît aux autres de l’égoïsme.
Et d’ailleurs, n’était-ce pas pour m’occuper d’eux que je vivrais loin de ceux qui se plaindraient de ne pas me voir, pour m’occuper d’eux plus à fond que je n’aurais pu le faire avec eux, pour chercher à les révéler à eux-mêmes, à les réaliser ? À quoi eût servi que, pendant des années encore, j’eusse perdu des soirées à faire glisser sur l’écho à peine expiré de leurs paroles le son tout aussi vain des miennes, pour le stérile plaisir d’un contact mondain qui exclut toute pénétration ? Ne valait-il pas mieux que, ces gestes qu’ils faisaient, ces paroles qu’ils disaient, leur vie, leur nature, j’essayasse d’en décrire la courbe et d’en dégager la loi ? Malheureusement, j’aurais à lutter contre cette habitude de se mettre à la place des autres qui, si elle favorise la conception d’une oeuvre, en retarde l’exécution. Car, par une politesse supérieure, elle pousse à sacrifier aux autres non seulement son plaisir mais son devoir, quand, se mettant à la place des autres, ce devoir quel qu’il soit, fût-ce, pour quelqu’un qui ne peut rendre aucun service au front, de rester à l’arrière où il est utile, apparaît comme, ce qu’il n’est pas en réalité, notre plaisir.
Et bien loin de me croire malheureux de cette vie sans amis, sans causerie, comme il est arrivé aux plus grands de le croire, je me rendais compte que les forces d’exaltation qui se dépensent dans l’amitié sont une sorte de porte-à-faux visant une amitié particulière qui ne mène à rien et se détournant d’une vérité vers laquelle elles étaient capables de nous conduire. Mais enfin, quand des intervalles de repos et de société me seraient nécessaires, je sentais que bien plutôt que les conversations intellectuelles que les gens du monde croient utiles aux écrivains, de légères amours avec des jeunes filles en fleurs seraient un aliment choisi que je pourrais à la rigueur permettre à mon imagination semblable au cheval fameux qu’on ne nourrissait que de roses.
Ce que tout d’un coup je souhaitais de nouveau, c’est ce dont j’avais rêvé à Balbec, quand sans les connaître encore, j’avais vu passer devant la mer Albertine, Andrée et leurs amies. Mais hélas ! je ne pouvais plus chercher à retrouver celles que justement en ce moment je désirais si fort. L’action des années qui avait transformé tous les êtres que j’avais vus aujourd’hui, et Gilberte elle-même, avait certainement fait de toutes celles qui survivaient, comme elle eût fait d’Albertine si elle n’avait pas péri, des femmes trop différentes de ce que je me rappelais. Je souffrais d’être obligé de moi-même à atteindre celles-là, car le temps qui change les êtres ne modifie pas l’image que nous avons gardée d’eux. Rien n’est plus douloureux que cette opposition entre l’altération des êtres et la fixité du souvenir, quand nous comprenons que ce qui a gardé tant de fraîcheur dans notre mémoire n’en peut plus avoir dans la vie, que nous ne pouvons, au dehors, nous rapprocher de ce qui nous paraît si beau au dedans de nous, de ce qui excite en nous un désir, pourtant si individuel, de le revoir, qu’en le cherchant dans un être du même âge, c’est-à-dire dans un autre être. C’est que, comme j’avais pu souvent le soupçonner, ce qui semble unique dans une personne qu’on désire ne lui appartient pas. Mais le temps écoulé m’en donnait une preuve plus complète, puisque, après vingt ans, spontanément, je voulais chercher, au lieu des filles que j’avais connues, celles qui possédaient maintenant cette jeunesse que les autres avaient alors. (D’ailleurs ce n’est pas seulement le réveil de nos désirs charnels qui ne correspond à aucune réalité parce qu’il ne tient pas compte du temps perdu. Il m’arrivait parfois de souhaiter que, par un miracle, entrassent auprès de moi, restées vivantes contrairement à ce que j’avais cru, ma grand-mère, Albertine. Je croyais les voir, mon coeur s’élançait vers elles. J’oubliais seulement une chose, c’est que, si elles vivaient en effet, Albertine aurait à peu près maintenant l’aspect que m’avait présenté à Balbec Mme Cottard, et que ma grand-mère, ayant plus de quatre-vingt-quinze ans, ne me montrerait rien du beau visage calme et souriant avec lequel je l’imaginais encore maintenant, aussi arbitrairement qu’on donne une barbe à Dieu le Père, ou qu’on représentait au XVIIe siècle les héros d’Homère avec un accoutrement de gentilshommes et sans tenir compte de leur antiquité.)
Je regardais Gilberte, et je ne pensai pas : « Je voudrais la revoir », mais je lui dis qu’elle me ferait toujours plaisir en m’invitant avec de très jeunes filles, pauvres s’il était possible, pour qu’avec de petits cadeaux je puisse leur faire plaisir, sans leur rien demander d’ailleurs que de faire renaître en moi les rêveries, les tristesses d’autrefois, peut-être, un jour improbable, un chaste baiser. Gilberte sourit et eut ensuite l’air de chercher sérieusement dans sa tête.
Comme Elstir aimait à voir incarnée devant lui, dans sa femme, la beauté vénitienne, qu’il avait souvent peinte dans ses oeuvres, je me donnais l’excuse d’être attiré par un certain égoïsme esthétique vers les belles femmes qui pouvaient me causer de la souffrance, et j’avais un certain sentiment d’idolâtrie pour les futures Gilberte, les futures duchesses de Guermantes, les futures Albertine que je pourrais rencontrer, et qui, me semblait-il, pourraient m’inspirer, comme un sculpteur qui se promène au milieu de beaux marbres antiques. J’aurais dû pourtant penser qu’antérieur à chacune était mon sentiment du mystère où elles baignaient et qu’ainsi, plutôt que de demander à Gilberte de me faire connaître des jeunes filles, j’aurais mieux fait d’aller dans ces lieux où rien ne nous rattache à elles, où entre elles et soi on sent quelque chose d’infranchissable, où à deux pas, sur la plage, allant au bain, on se sent séparé d’elles par l’impossible. C’est ainsi que mon sentiment du mystère avait pu s’appliquer successivement à Gilberte, à la duchesse de Guermantes, à Albertine, à tant d’autres. Sans doute l’inconnu, et presque l’inconnaissable, était devenu le connu, le familier, indifférent ou douloureux, mais retenant de ce qu’il avait été un certain charme.[…]
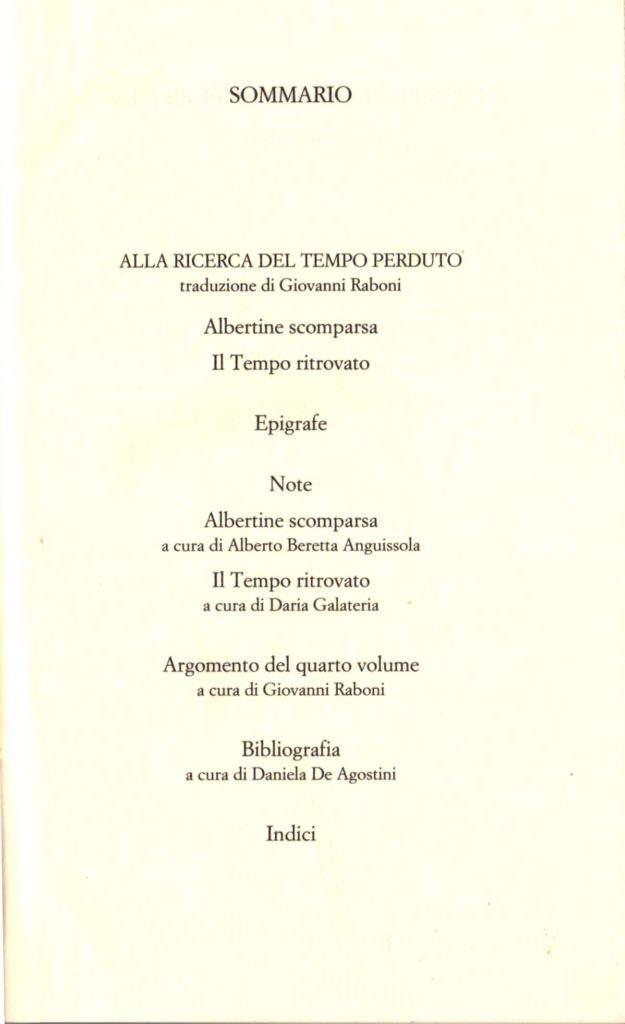
Il Tempo ritrovato – Note – a cura di Daria Galateria
A metà agosto del 1909, dal Grand Hôtel di Cabourg dove si alza o le nove e mezza di sera, Proust scrive a Madame Straus: «Mi leggerete — e più di quanto non vorreste — perché ho appena cominciato — e finito — tutto un lungo libro… Tutto è scritto, ma molte cose sono da rimaneggiare». Proust intendeva dire che, del suo romanzo «troppo sconveniente» e «troppo lungo» (Corr. IX, p. 163), ha steso, di seguito, l’inizio, e la fine: «Quest’opera è così meticolosamente “composta”… che l’ultimo capitolo dell’ultimo volume è stato scritto immediatamente dopo il primo capitolo del primo volume. Tutto quello che c’è in mezzo è stato scritto dopo, ma tanto tempo fa», spiegherà, dieci anni più tardi, nel dicembre del 1919, a Paul Souday (Corr. XVIII, p. 536).
Le primissime tracce del Tempo ritrovato si affacciano già nel Cahier de 1908: i motivi della vecchiaia e della memoria involontaria («noi crediamo che il passato sia mediocre perché lo pensiamo ma il passato non è questo, sono le pietre sconnesse del Battistero San Marco»), e il passaggio: «Alberi non avete più nulla da dirmi», che riaffiora, come citazione dell’epoca dell’impotenza letteraria, nella sequenza della riflessione estetica, l’Adoration petpétuelle — che, per essere collocata durante la matinée dai Guermantes, Proust chiama ironicamente «l’estetica nel buffet» (CMP 8, pp. 59, 60 e 52). E naturalmente molti momenti di questa meditazione sono presenti nei primi dieci quaderni preparatori della Recherche, quelli chiamati Contre Sainte-Beuve perché Proust esita tra il romanzo e il progetto di un saggio polemico sul metodo del grande critico. Accanto alle prime stesure delle fantasticherie del risveglio, e ad altri temi poi dispersi nella Recherche, i Mémoires d’outre-tombe di Chateaubriand offrono in quelle pagine alcuni esempi delle intermittenze del cuore, che riappariranno nel Tempo ritrovato; le lastre sconnesse in un cortile tornano a restituire Venezia, e il colpo di un cucchiaio su un piatto, riportando alla memoria rumore delle ruote di un treno battute dal martello del macchinista, resuscita un’antica giornata di viaggio; e insufficiente è dichiarato il ruolo dell’intelligenza nella rievocazione del passato (CSB, pp. 652-3, 212-3).
[pag. 924 Note] Ma è in effetti a partire dalla primavera del 1909, nell’ultimo dei quaderni Sainte-Beuve, il 51, che alla comparsa di un ricevimento dai Guermantes — per ora, una «serata»; certi ospiti resteranno in abito scuro ancora dentro alla finale «matinée» — il Tempo ritrovato, si affaccia definitivamente; snoda i primi ritratti dei suoi personaggi «incipriati» dal tempo «come in un bal de tétes», e il barone Charlus — che per il momento si chiama marchese di Guercy – scuote con la ritmica e inaudita deferenza del suo decadimento fisico la superba chioma argentea, con l’eloquenza da barocca orazione funebre alla Bossuet che resterà inalterata nel successivo decennio di elaborazioni. Nel Quaderno 58, del 1910, l’estetica del buffet è animata da un colloquio con Bloch successivamente abbandonato. Il Quaderno 57, del 1910-11, delinea la prima versione. continua dell’Adoration perpétuelle e del Bal de Tétes. Dallo studiolo-biblioteca del principe di Guermantes, adiacente alla sala rinfresco, arrivano le note di Wagner, il Parsifal, con l’Enchantement du Vendredi saint; dopo aver esitato tra la troppo scoperta metafora della ricerca del Graal e l’evocazione del Quartetto Vinteuil, Proust sceglierà alla fine di lasciare alla musica un riferimento di tono grottesco (cfr. p. 734), per concentrare le luci sulla creazione letteraria. Sul finale tentennano anche i personaggi del Narratore, precariamente arrampicati — e fin dal Quaderno 51 sugli immensi trampoli del Tempo.
Il 28 ottobre 1912 Proust descriveva così il suo romanzo a un editore, Eugène Fasquelle: «Do al primo volume il titolo Il Tempo perduto. Se riesco a far stare tutto il resto in un solo volume lo chiamerò Il Tempo ritrovato» (Corr. XI, p. 257; l’insieme del romanzo è chiamato nella lettera l’Adoration perpétuelle; per il titolo Tempo ritrovato cfr. vol. II, p. 1209, nota 2 di p. 910). Nel corso degli anni, con la guerra che rinviava la pubblicazione del romanzo, il quale a sua volta per effetto del ritardo si estendeva, il Quaderno 57 trasformava in un palinsesto, accogliendo una miriade di note intermittenti che trasfiguravano alcuni invitati della matinée; Ma me Verdurin diventava duchessa di Duras, preparando il colpo di scena della versione finale; e intanto si operava una trasformazionde ancora più stupefacente nell’estetica del Narratore, che maturava una parziale riconciliazione con l’intelligenza. Il suo ruolo nella ressurrezione del tempo perduto oscilla («quando l’interroghiamo sul passato, su coloro che abbiamo amato… è di altri esseri che ci parla, e dei morti che abbiamo perduto ci fornisce un ricordo che è l’inizio dell’oblio… lo slancio originale che è come un battito, l’atto stesso della vita, non è intellettuale», ma: «quello che la sensibilità e l’intelligenza ci dicono su una stessa cosa differisce… come se la nostra natura non fosse capace di stringere insieme il particolare e
[Il Tempo ritrovato pag. 925] risalire al generale, correndo continuamente dalla sensibilità che afferra l’uno all’intelligenza che rimonta fino all’altro per cercare di esprimere tutta la realtà»; i Quaderni 51, 58 e 57 sono stati pubblicati nel 1982 da H. Bonnet e B. Brun nella Matinée chez la princesse de Guermantes, Gallimard; cfr. pp. 359, 361, 360, 37).
Nel cuore della Grande Guerra, e soprattutto a partire dal 1916, il Tempo ritrovato si arricchisce di tutto. un universo, che Proust sintetizza in una lettera del dicembre del 1919, con una folgorante e ironica attenuazione: «Alla pubblicazione di Swann nel 1913, erano già scritti non soltanto A l’ombre des jeunes filles en fleurs, Le Côté de Guermantes e il Temps retrouvé, ma anche una gran parte di Sodome et Gomorrhe. Ma durante la guerra (e senza toccare niente nella fine del libro Le Temps retrouvé) ho aggiunto qualche cosa sulla guerra che conveniva al carattere del signor di Charlus» (lettera a Rosny aîné, Corr. XVIII, p. 546). L’evocazione della guerra, i nuovi linguaggi e gli usi che suscita, il disfattismo di Charlus e il bordello di Jupien, tutte le alterazioni che il conflitto induce in Parigi — buia e silenziosa come Combray durante l’oscuramento, wagneriana nel corso dei bombardamenti, mondana o dannata nei suoi inferi, i rifugi dei grandi alberghi e i sotterranei del métro — sono miniaturizzati da Proust nel suo «qualcosa sulla guerra»; queste sequenze, le cui prime versioni ci restano in parte ignote, sono probabilmente completate nel 1919, al momento della pubblicazione delle Fanciulle in fiore, che annunciano in copertina, come finale del romanzo: «Nuovo aspetto di Robert de Saint-Loup [il soggiorno a Tansonville, e l’omosessualità di Saint-Loup, sono inclusi allora in Albertine scomparsa, mentre il ritorno a Tansonville verrà alla fine diviso tra i due ultimi volumi]. Il signor di Charlus durante la guerra: le sue opinioni, i suoi piaceri. Matinée dalla principessa di Guermantes. L’adorazione perpetua. Il Tempo ritrovato».
Dai tempi di Sodoma Proust stendeva il manoscritto del romanzo sui quaderni di scuola che numerava, in cifre romane, da I a XX. Dalla metà del XV all’ultimo, sono occupati dal Tempo ritrovato, a cui Proust appose la parola «Fine» nella primavera del ’22, dicendo a Céleste, «giubilando come un bambino», che ora poteva morire. Morì in effetti prima di aver fatto eseguire il dattiloscritto dei quaderni del Tempo ritrovato. Nell’autunno del 1922 la guerra era così presente alla coscienza, che nella camera mortuaria di Proust Coc-teau disse che i quaderni neri da scolaro battevano ancora, come un orologio al polso di un soldato morto (Le Passé defini, Paris, Gallimard, 1983, p. 275). Il Tempo ritrovato uscì in due volumi, nel 1927, presso la «Nouvelle Revue Française»; come gli altri volumi postu-mi, La Prigioniera e Albertine scomparsa, era curato da Robert Prou-
[pag. 926 Note] st, aiutato da Jean Paulhan. Il manoscritto, che Proust rimaneggiò fino alla fine, era ancora da rivedere: affiorano alcuni errori e che ripetizione, due personaggi risuscitano, talvolta le aggiunte sono di dubbia collocazione; soprattutto, Proust non ha probabilmente fatto in tempo a integrare nel testo certi passaggi magistrali, la rivelazione, introdotta nel modo più inatteso, improvviso e certamente per il lettore — e per Madame Cottard, che ne rinviene traccia nelle lettere del marito defunto —, di un’antica e mai sospesa relazione del dottor Cottard con Odette (Eugène Nicole e Brian Rogers l’hanno trascritta alle pp. 975-8 del vol. IV della nuova edizione Gallimard, «Pléiade», 1989, della Recherche: «Certo, Madame Forcheville, negli ultimi tempi della vita di Cottard, che forse aveva abbreviato, esercitava solo occasionalmente il suo antico mestiere di cocotte — ma dall’averlo imparato secondo le regole e conosciuto a fondo, le restava nell’esecuzione delle carezze una sfumatura inimitabile che distingueva ancora, qualche anno fa, le sopravvissute dell’Ancien Theatre. Forse da questo punto di vista si sarebbe potuto rimproverare alla sua recitazione qualcosa di troppo Conservatorio. Si restava stupiti a vederla far regolarmente precedere o se certi baci da una serie di quelle fioriture senza le quali le maestre del bel canto non credevano di poter affrontare la scena. Così non era solo dal riso chiaro e sbarazzino con cui accompagnava la conversazione mondana che si riconosceva in lei la grande cocotte formatasi alla fine del Secondo Impero, ma dallo stile con cui cantava pezzi sempre identici dei duetti amorosi. Ci si stupiva, non avendo l’abitudine a quei vocalizzi, ma presto si restava incantati, e ci si riva soddisfatti…»). Valga per tutti i testi abbandonati questo passaggio sull’amore: «come sembra più bella la donna che non si può avere, che è lontana, inaccessibile, per la quale si darebbe cento volte quella cosa mediocre che lei stessa potrà diventare un giorno che è stata forse un tempo: la donna posseduta» (Quaderno 18, ff. 129-30).
Nonostante questa complessa stratificazione, e lunga sedimentazione del Tempo ritrovato, l’orchestrazione dei rimandi e dei riferimenti risponde a una strategia rigorosa. Proust accalca nelle sequenze di Tansonville e della guerra una rete di richiami al mondo in esterno al romanzo più fitta dell’ordinario. Si affollano le allusioni al genere letterario che domina l’apertura del volume, la memorialistica, e secondo l’uso consueto il passaggio del bordello di Jupien affonda nelle citazioni apparentemente più distratte — e più innocenti — tutti gli abissi di Sodoma. Nella seconda parte del volume invece, per la prima volta, la tattica di Proust si rovescia; lo sci re tende piuttosto a eliminare, dalle versioni antiche dell’Adoration
[Il Tempo ritrovato pag. 927] perpétuelle e del Bal de Tétes, i segni del mondo reale. Proust mira comporre un universo ormai autosufficiente, in cui il pensiero etico non esce più a confrontarsi con gli artisti amati, e il racconto non è più percorso dai riferimenti alla vita contemporanea. Inversamente, compaiono, disordinati e continui, i richiami al passato del testo, ai più disparati momenti del romanzo, quelli contigui o i più lontani (dove l’indice non può orientare il lettore, si è provveduto in nota a rinviarlo agli episodi evocati dal Narratore). Al momento delle prime stesure, si trattava di rievocazioni anticipate; al tempo della versione definitiva, è come se il Narratore diventasse memorialista del suo romanzo a venire. Nella distribuzione delle arti lungo il corso della Recherche, è la memorialistica che Proust porta fino al limitare dell’Adorazione rpetua. ll pastiche dei Goncourt è solo il segmento di superficie tutto un sistema di fitti riferimenti al genere, concentrato soprattutto in Tansonville e nell’evocazione della Grande Guerra. Già nelle primissime versioni della Recherche, le memorie tanto amate dalla nonna, e che saranno attribuite alla fine all’immaginaria Madame de Beausergent, erano dapprima ascritte alla Sévigné o a Charlus, appartenevano alternativamente alla biografia di Proust (a cui la madre citava volentieri la marchesa) o alla parte di Guermantes. Ora, nel Tempo ritrovato, l’intreccio delle due strade è applicato alle memorie della Beausergent, in cui compare, adorabile, il piccolo Basin de Guermantes — analogamente la Boigne, modello a Beausergent, scrive i suoi Récits d’une tante per il nipote prediletto, e «per il bisogno di vivere nel passato». Nella scelta finale Proust interviene anche un argomento biografico: «Mi ricordo», scrive nel 1907, «che i miei genitori hanno spesso cenato col nipote di Madame de Boigne, di cui ho trovato la fotografia tra le loro carte; tutto questo tesse una trama di frivolezze, poetica però… per redendere più viva la storia, e quasi storica la vita» (p. 362). Proust ama nelle memorie il legame organico, vitale, con l’esistenza — la loro «frivolezza» — e il volteggiare vorticoso dei ritratti, resi ancora più instabili e cangianti dal mutevole sguardo del diarista, che si sforma mentre scrive, e il tempo trascorre. Ma Proust rimprovera alle memorie di rappresentare la realtà caduca; il romanzo, nel creare figure universali, è superiore, perché sfugge al tempo. Tutti i riferimenti sotterranei ai Goncourt, che nel pastiche appaiono accecatati dal particolare e dall’evento, prediligono sistematicamente i passsaggi rimemoranti: le sequenze in cui Edmond rievoca i genitori, la zia che lo ha formato all’arte, antiche passeggiate, le cene di tempo col fratello ancora vivo nelle vecchie case (nota 3 di p. .3; nota 2 di p. 355; nota 2 di p. 357, e così via); persino uno straziante accenno a Napoleone in esilio e malato (p. 361). Le «chiavi»
[pag. 928 Note] non hanno più interesse del ramo di pino nelle saline, aveva scritto Montesquiou a Proust (cfr. nota 1 di p. 350); la cristallizzazione del sentimento è quella che dà eternità al diario, sembra credere Proust, dal momento che, secondo una sua abitudine, lascia scorrere nella falda nascosta delle citazioni e delle fonti la corrente sotterranea e più significativa delle memorie, quella per cui dichiarerà fine del romanzo di voler essere il Saint-Simon del suo tempo.
Le appassionate proteste proustiane sulla separazione tra l’io sociale e l’io che scrive — paragonata in una bellissima pagina vanile (CSB, p. 420) alla scissione tra il dottor Jekyll e Mister Hyde — nel Tempo ritrovato subiscono una forte attenuazione. Sulle «chiavi» e i modelli dei suoi personaggi, Proust dà indicazioni contraddittorie (pp. 517, 583); e proprio dove assicura con grande calore che l’unico nome che corrisponde a persone reali è quello Larivière, i parenti ricchi di Françoise (p. 518), attribuisce loro edificante episodio di guerra in cui molti particolari sono sfuggenti,e che Céleste, nel suo Monsieur Proust, non accredita. La distanza tra il Narratore e lo scrittore si accorcia; come nella Prisonnière. per il protagonista chiamato, per una volta, Marcel, qui una serie di lievi allusioni — alla traduzione di Sésame et les lys di Ruskin, Plaisirs et les jours «primo libro dell’autore», alle paperoles (pp. 502; 752; 594 e 743) — fanno segno a un sottinteso: un’identità, o meglio un travestimento.
«Il pittore ha un quaderno di schizzi rapidi», scrive Proust in un testo preparatorio del Tempo ritrovato in cui spiega la condensazione di molteplici modelli in un solo personaggio (cit. ed. del 1989 della Recherche, vol. IV, p. 863); «così lo scrittore… dettava inconsciamente al suo orecchio e ai suoi occhi di trattenere sempre l’accento con cui era stata detta una frase, e l’aria della figura e il movimento di spalle che aveva fatto a un certo momento, tanto tempo prima, una persona di cui non sa magari nient’altro e questo perché quell’accento, quell’aria, li aveva già ascoltati e visti, vi sentiva qualcosa di universale, dunque di rinnovabile, di durevole». Nel tratteggiare l’epoca della guerra, Proust sembra guidato una preoccupazione simile; seleziona nell’universo «piuttosto inaudito» — come dice Saint-Loup — creato dal conflitto i temi che ritornano. Parla di un episodio minore, la spedizione di Mesopotamia, perché le truppe anglo-indiane replicano a ritroso, nelle stesse impossibili condizioni e con gli stessi immemorabili mezzi, la «spedizione eccentrica e favolosa» dell’Anabasi di Senofonte, duemila anni prima. Negli anni di guerra, Proust legge giornalmente le cronache militari di Henry Bidou e di Joseph Reinach, citandone e parafrasando, nel Tempo ritrovato, proprio i passaggi in cui la strategia ripropone gli stessi modelli di battaglia — «È ben difficile che in
[Il Tempo ritrovato pag. 929] una manovra di Hindenburg non si ritrovi un modello napoleonico», scriveva Bidou; che pure ricordava le previsioni di Moltke, quando vedeva la storia replicarsi. Ovvero Proust privilegia i momenti in cui le crisi d’Oriente rievocano a Reinach la Bagdad delle Mille e una notte, o appunto la ritirata di Senofonte (pp. 347; 409; 426; 680; 682, eccetera). Parigi invasa dalle truppe di venticinque nazioni alleate è variopinta come una tela di Carpaccio, e tutta la sequenza sulla guerra è dominata dal parallelo con l’epoca del Direttorio (pp. 369; 373, eccetera). Se l’accostamento di due istanti della memoria involontaria li emancipa dal tempo, il ritorno, per la storia, è una forma di continuità e di resurrezione.
Le brusche e imprevedibili mutazioni dei personaggi e delle situazioni rispondono a una funzione solo apparentemente inversa; garantiscono la vitalità, il comico, estroso, paradossale, continuo slancio dell’esistenza. Così, tra i personaggi rivelati dalla guerra, Proust fa cenno a Reinach, perché, panamista e dreyfusista, e poi sostenitore del riarmo e commentatore bellico, dopo esser stato per lungo tempo esecrato come nemico dell’esercito di Francia, diventa, durante il conflitto, il beniamino dei salotti (nota 2 di p. 373; e cfr. Galliffet, p. 378). Questo tipo di rovesciamenti e rivoluzioni nei caratteri e nei destini, come pure nelle funzioni delle opere letterarie citate nel testo, è così diffuso nella Recherche che basta soffermarsi su due soli casi, perché sottopongono a una vera convulsione geologica — che è la metafora con cui Proust designa la guerra — due libri per l’infanzia. Le fiabe delle Mille e una notte decoravano i piatti fantasmagorici di Combray. Un giorno, a Balbec, la mamma aveva regalato al Narratore una nuova versione delle fiabe, più «licenziosa», con i nomi amati dei personaggi e dei geni così alterati che l’esotismo aveva subìto un’ulteriore accelerazione (era la versione del libertino Mardrus, che appartiene, con la moglie, amica di Natalie Clifford Burney, all’universo di Gomorra, vol. III, p. 855, nota I di p. 63). In apertura di Sodoma, Charlus «perlustra» le notti di Parigi come il califfo Haroun al-Rashid in cerca di avventure (vol. II, pp. 1165-6, nota I di p. 740). Ora, nel Tempo ritrovato, è il Narratore che si perde — come il califfo nel «vecchio Oriente» della sua Bagdad (profumata, leggendaria Babilonia negli articoli di Reinach, p. 682) — nella Parigi notturna oscurata dalla guerra, saldando i percorsi di Proust, del Narratore e di Charlus (nota 2 di p. 474, e nota 1 di p. 511). In superficie si raccontano, delle fiabe, piccoli episodi ordinari di magia o di stupore: un palazzo trasportato per incantesimo (p. 352); Aladino che scopre accidentalmente il metodo per fare apparire il Genio (p. 545); una fanciulla che senza motivo apparente percuote una cagna (p. 501). Rileggendo le
[pag. 930 Note] fiabe citate, compare tutta un’altra storia sotterranea. Così si dispera Aladino nella settecentotrentanovesima notte: «Si vedeva sotterrato vivo tra le quattro mura della caverna piena di buio e terrore. E singhiozzò a lungo, affondato nel suo dolore. E, per la prima volta nella sua vita, si mise a pensare a tutte le bontà della sua povera madre e alla sua devozione instancabile, malgrado lui si comportasse male e fosse ingrato. E la morte in quella grotta gli sembrò ancora più amara, per il fatto di non aver saputo, durante la vita, rinfrescare il cuore della madre migliorando in quale modo il suo carattere e mostrando qualche sentimento di riconoscenza. E sospirò molto a questo pensiero, e si torse le braccia e si strofinò le mani, come fanno i disperati». La segregazione – che normalmente è segregazione amorosa, e come tale è comparsa ad esempio sotto una citazione di Balzac (nota 1 di p. 348) — è qui la clausura che prelude alla morte, resa più disperata dal rimorso «matricida». Nella settecentosessantesima notte, la madre di Aladino è compensata con un favoloso palazzo e abiti magnifici e quando scopre il viso davanti al sultano, «lui notò, dalla delicatezza dei tratti, che doveva essere stata ben attraente da giovane che… aveva un’aria da gran signora, più di molte principesse e mogli di vizir e di emiri» (p. 501).
L’ultimo riferimento ci trasporta di colpo nel mondo dell’uomo delle catene; un’intera costellazione di favole attinenti mette in scena uomini e donne flagellati. «Ogni giorno mi tortura e mi frusta con una correggia di cuoio» si lamenta un giovane nell’ottava notte, «e mi dà cento colpi fino a farmi sanguinare tutto. E poi mette direttamente sulla pelle, sotto i vestiti, una veste di pelo mi copre interamente il busto»; nella stessa notte, la storia così prosegue: «La debosciata… spogliò il figlio di suo zio, prese frusta e lo colpì. Allora lui gridò: “Ahi! ahi! basta! il mio dolore è già abbastanza terribile! Oh! Abbi pietà di me!»». Nella decima notte, la giovane Amina, dopo un disperato canto d’amo strappa le vesti e sviene: «ll califfo si accorse che il corpo, messo a nudo da questo movimento, era segnato da colpi di frusta e di verga». Più avanti Amina spiega l’origine di quelle ferite, la gelosia marito: «Diede ordine ai negri, che, subito, mi spogliarono di tutti i vestiti e mi esposero così completamente nuda. Allora prese stesso un ramo flessibile di cotogno e si mise a fustigarmi per tutto il corpo, e specialmente sulle spalle, il petto e i fianchi, e tanto a lungo, e così forte e con tale furia che persi conoscenza, dopo aver perso ogni speranza di sopravvivere a tali colpi»; e così via. Ma il libro di fiabe che subisce la più spaventosa metamorfosi è quello di La Fontaine. Tornano, nel Tempo ritrovato, Les deux pigeons, con la loro tenerissima scuola dei sentimenti, già utilizzata
[Il Tempo ritrovato pag 931] nelle Fanciulle in fiore per comporre lo schizzo della «sensibilità femminile» di Charlus (vol. I, p. 925 e relativa nota 1, p. 1308). Ma è una delle più profonde fantasie di Proust che trova la sua via attraverso i ritornelli e le rime infantili di La Fontaine. Proust aveva scoperto antecedenti letterari a questa sua ossessione in Saint-Julien l’hospitalier di Flaubert; il primo atto sadico del santo era stato di trafiggere un topo con uno spillo e di fissare ammaliato la goccia di sangue (vol. II, pp. 1211-3, nota 1 di p. 923). Nella zona più riposta della sua vita, chiamavano Proust l’«uomo dei topi», per una sua perversione affiorata negli ultimi anni. Lo scrittore si faceva portare dei topi in una gabbietta, e li faceva liberare e bastonare, o trafiggere con lunghi spilloni, da giovanotti in tenuta adamitica. Con l’infinita, sensibile crudeltà con cui conosceva gli altri e se stesso, Proust aveva individuato, in questo atto sadico, un nodo tra la fantasia di aggressione anale, e i contraddittori sentimenti di colpa, ribellione e rivendicazione che nutriva nei confronti dei genitori morti (cfr. vol. II, p. 102 e relativa nota 2, p. 979). Come si sa, tutto avveniva nel bordello di Albert Le Cuziat, che era stato a suo tempo un valletto nell’alta società parigina, e aveva poi rilevato, con l’aiuto finanziario di Proust, l’ Hôtel Marigny, arredandolo —soprattutto l’ingresso e la sua camera da letto — con i mobili di casa Proust, che stavano ammassati in un magazzino dal 1906 (nelle Fanciulle, il Narratore regala alcuni mobili della zia Léonie alla tenutaria della casa chiusa cui lo ha introdotto Bloch, cfr. vol. I, pp. 698-9 e p. 1282, nota 1 di p. 698). Con le competenze acquisite nelle grandi case di Parigi, e nel bordello, Albert Le Cuziat, che Proust chiamava «il mio Gotha vivente», forniva allo scrittore alternativamente, oltre ai topi, genealogie, nozioni di protocollo, e racconti sui vizi della clientela (cfr. ad esempio M. Sachs, Le Sabbat, Paris, Corrêa, 1946, pp. 283-6). In un inverno parigino, Walter Benjamin, che fu traduttore di Proust, fu indotto a visitare, con lo scrittore Maurice Sachs, il «pittoresco» e «modesto» casino di Albert Le Cuziat, e il suo racconto — «l’ingenuità, l’ostinazione giovanile» dei ragazzi, Monsieur Albert «incredibilmente bello», nella sua «completa compenetrazione della massima sottomissione e dell’estrema decisione che caratterizza il lacchè, come se la casta dei signori non possa divertirsi che a comandare persone che abbiano l’aspetto di comandanti», la «catastrofe finanziaria» in cui si risolve per lui, al ristorante, la serata — costituisce uno dei più bei corollari all’evocazione proustiana del bordello per omosessuali (Abend mit M. Albert, Gesammelte Schriften, Suhrkamp, Frankfurt am Mein, 1972-89, IV, t. I, pp. 587-91). Ora, nel Tempo ritrovato, con sibillina sottigliezza, una superba, settecentesca edizione illustrata di La Fontaine, e una sua candida immagine, con un mare
[pag. 932 Note] tutto ondoso e gremito di vascelli, permette a Proust di evocare Le rat et l’huitre, che mette in scena un topo sgozzato da un’ostrica (p. 353). Più avanti (p. 527), occultata dentro un gioco di parole su un partito politico, si affaccia Le chat et un vieux rat, dove ancora più esplicitamente imperversa un gatto sterminatore, un Attila, flagello dei topi, che «voulait de souris dépeupler tout le monde» (voleva dai topi spopolare il mondo). Così le Mille una notte e le favole di La Fontaine, ancora impregnate della magia della lettura infantile (p. 474), entrano nel bordello di Jupien. Poi i riferimenti al mondo esterno al romanzo cominciano a diradarsi. Durante la matinée, si intensificano ancora i richiami al passato del Narratore, e si rarefanno le citazioni del reale, che non ha più bisogno di essere incorporato al romanzo per sopravvivere, nel modo aneddotico in cui operano le memorie. Nel trascrivere le vecchie versioni dell’Adoration perpétuelle e del Bal de Tétes, Proust espunge i riferimenti agli scrittori contemporanei, cancella perfino Pascal e Wagner; lascia affiorare nel testo la possente semplicità di Hugo, e Chateaubriand e Nerval, perché, retrospettivamente, possono considerarsi i primi narratori dei momenti privilegiati della memoria. Le reminiscenze involontarie sono fuori del tempo, e anche il romanzo. Una volta messa a punto, la grande macchina contro la morte inizia a muoversi, e diventa sufficiente.
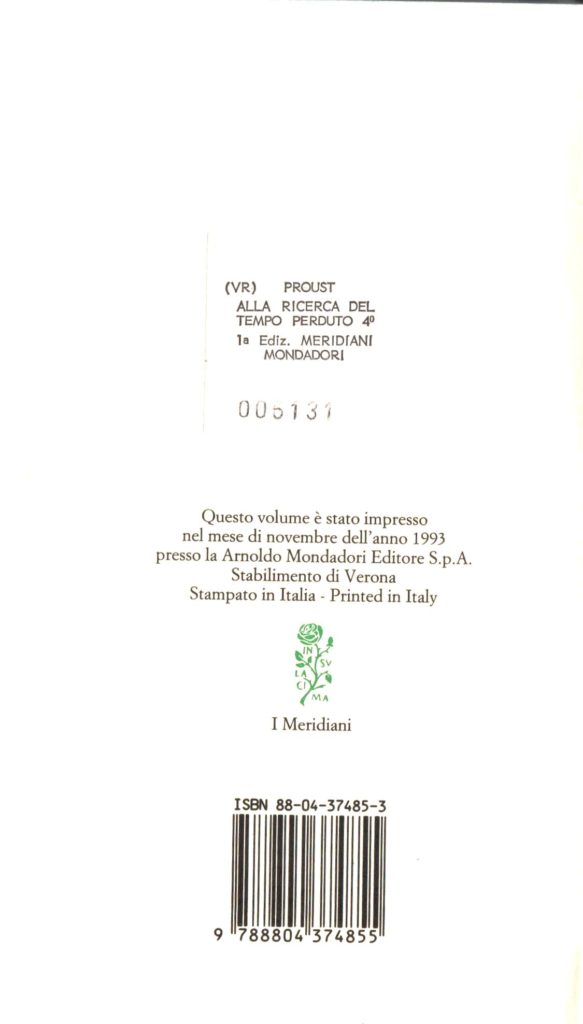
Questa annotazione, iniziata dodici anni fa, in assenza di precedenti lavori consimili, ha goduto per il presente volume del conforto della pubblicazione, nel frattempo intervenuta, di alcune edizioni annotate, in particolare di quelle di Bernard Brun (Flammarion, 1986) e di Jacques Robichez e Brian Rogers nella nuova «Pléiade» del 1989. Naturalmente — secondo l’uso di questa edizione, che, a costo di appesantire le note con continui rimandi, rinvia sempre alle sue fonti — i curatori sono citati ogni volta che il loro commento è stato utilizzato, e qui li ringraziamo. La mia gratitudine va pure all’indimenticabile direttore di questa edizione, Luciano De Maria, a Giovanni Macchia, che ha promosso e seguito il lavoro con la sua insuperata competenza proustiana, a Giorgio Agamben, Aurelio Andreoli, Mara Fazio, Mario Molinari, Michele Surdi e Niccolò Zapponi che mi hanno soccorso su alcuni problemi esegetici; e a Marco Beck e Gabriella Mezzanotte per lo vigile opera redazionale. D.G.
Alla ricerca del tempo perduto.
L’opera è suddivisa, per motivi editoriali, in sette capitoli:
Dalla parte di Swann o La strada di Swann (Du côté de chez Swann, 1913)
All’ombra delle fanciulle in fiore (À l’ombre des jeunes filles en fleurs, 1919, premio Goncourt)
La parte dei Guermantes (Le côté de Guermantes, 1920).
Sodoma e Gomorra (Sodome et Gomorrhe, 1921-1922)
La prigioniera (La prisonnière, 1923)
Albertine scomparsa, (La fugitive ossia Albertine disparue, 1925)
Il tempo ritrovato (Le temps retrouvé, 1927)
Marcel Proust
À la recherche du temps perdu
Tome IV
Édition publiée sous la direction de Jean-Yves Tadié avec la collaboration d’Yves Baudelle, Anne Chevalier, Eugène Nicole, Pierre-Louis Rey, Pierre-Edmond Robert, Jacques Robichez et Brian Rogers
Nouvelle édition. Avec des index des noms de personnes, des noms de lieux et des œuvres littéraires et artistiques
Parution le 4 Octobre 1989
Bibliothèque de la Pléiade, n° 356
Gallimard
Achevé d’imprimer le 24 Juillet 1989
1728 pages, rel. Peau, 105 x 170 mm
ISBN : 9782070111640
Code distributeur : A11164
GENCOD : 9782070111640
Ce volume contient
Albertine disparue – Le Temps retrouvé – Esquisses.







